L'Associazione Isola di Graziella incontra Pino Boero
 |
| Pino Boero e Walter Fochesato a Procida sul tetto del Palazzo d'Avalos |
Nell'ambito del Progetto "Procida - Il mondo salvato
dai ragazzini - Elsa Morante" promosso dal Comune di Procida e di cui
l'Associazione Isola di Graziella è Partner, c'è stato a Procida, nel gennaio 2020, anno in
cui si celebravano i 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari, l'importante
incontro con i massimi esperti dell'opera di Rodari, Walter Fochesato e Pino
Boero. L'Associazione Isola di Graziella si è preoccupata di accoglierli al porto,
far loro visitare l'isola, il Palazzo d'Avalos e la Biblioteca, ospitarli nelle
case dei volontari e poi ha partecipato
all'incontro importantissimo tenutosi alla scuola Media A. Capraro con tutti i
docenti partecipanti al Progetto, Un incontra straordinario per l'intensità dei
contenuti e per il rapporto profondo che si è costruito con i due relatori,
presentati all'assemblea dei partecipanti dalla giornalista Donatella Trotta.
In particolare è nato un rapporto diretto
tra l'Associazione Isola di Graziella e Boero e Fochesato da cui è
scaturita una prima intervista a Pino Boero pubblicata nel Giugno 2020 sul
periodico nazionale Città Nuova, che vogliamo far conoscere a quanti sono interessati al
Progetto "Procida-Il mondo salvato dai ragazzini - Elsa Morante".
L'indispensabile letteratura per
l'infanzia
in una Scuola che privilegi il rapporto
diretto, personale empatico tra bambino e adulto.
Incontro con Pino Boero
In un momento in cui la scuola si dibatte tra due direttive, spesso
divergenti: innovazioni tecnologiche e programmazione scandita temporalmente con relative valutazioni da una
parte e spinta a riconsiderare la centralità dell'allievo e la sua
formazione al bene relazionale puntando "sul rapporto diretto, personale,
empatico fra bambino e adulto" dall'altra, la figura di Pino Boero prende
oggi particolare risalto in quanto egli
ci porta a considerare con più attenzione la centralità dell'alunno in ogni
progetto didattico.
Considerato tra i massimi esperti al mondo della letteratura per
l'infanzia e della storia dell'educazione, egli sottolinea l'importanza dell'esperienza pedagogica di
Gianni Rodari, Mario Lodi, Albino Bernardino e Maria Luisa Bigiaretti per
un'impostazione didattica aperta alla fantasia e alla creatività, con
esperienze ricche di sollecitazioni formative, considerando criticamente la
burocratizzazione in atto nella scuola e
la trasformazione del profilo professionale dei dirigenti scolastici ai
quali sempre più vengono chieste " competenze economiche e di diritto e minori competenze
didattiche, pedagogiche e psicologiche."
Ho incontrato Pino Boero in un seminario su Gianni Rodari, di cui
ricorre quest'anno il centenario della nascita, a Procida in un incontro per i
docenti di tutte le scuole impegnate nel progetto di educazione alla lettura:
"Procida. Il mondo salvato dai ragazzini. Elsa Morante"
Come nasce la tua passione per la letteratura dell'infanzia?
Nasce da lontano, quando studente
universitario, alla fine degli anni Sessanta del secolo scorso, collaboravo
alla pagina dei libri del quotidiano genovese "Il Secolo XIX" e il
caporedattore mi dava da recensire, fra l'altro, i testi per bambini che, per
quei tempi erano considerati "rivoluzionari" o almeno
"strani", dagli albi della Emme Edizioni di Rosellina Archinto a
quelli di Munari, ai libri di Rodari stesso. Da bambino e ragazzo, inoltre, io
ero stato un grande lettore di fiabe, di Salgari e dell'avventura e avevo quindi
un "precedente" nella mia formazione…
Indifferenza e sottovalutazione, due atteggiamenti che hanno portato a
considerare la letteratura per l'infanzia come una sottospecie. Cosa ha
determinato questo atteggiamento diffuso?
Sostanzialmente direi che l'indifferenza e la
sottovalutazione nascevano dalla non conoscenza: Rodari sosteneva con amara
ironia di essere - come tutti gli altri autori per l'infanzia - uno scrittore
di "serie B"… Niente di più falso ma è difficile far capire non solo
ai semplici lettori ma anche agli intellettuali che la scrittura per l'infanzia
ha una sua autonomia, va giudicata con un metro capace di mettere insieme
letteratura, pedagogia, psicologia, storia, antropologia, sociologia… Ma
soprattutto va ribadito il concetto che scrivere per l'infanzia non è affatto
una "bambinata" ma richiede un lavoro
supplementare di elaborazione… Rodari stesso non scriveva di getto,
appuntava idee, le rielaborava e correggeva… insomma la letteratura per
l'infanzia appartiene a pieno diritto alla "serie A"…
All'inizio degli anni Settanta (1972) trovo
significativi due eventi: la pubblicazione di Guardare le figure (Einaudi) di Antonio Faeti che
rivoluziona, attraverso la storia di "figurinai" e illustratori, il
modo di interpretare i libri per bambini e l'inaugurazione a Milano della
Libreria dei Ragazzi di Roberto e Gianna Denti che conferiscono piena autonomia
al "genere". Nello stesso tempo nelle Università comincia un lavoro
di studio e ricerca molto specifico: a Padova Anna Maria Bernardinis
approfondisce i temi pedagogici della materia, a Bologna Faeti continua a
lavorare sulle connessioni fra testo, immagini e altri media (fumetti, cinema…), a Genova io, non ancora docente della
materia ma professore di Letteratura
italiana contemporanea, studio gli autori dal punto di vista
storico-letterario… le connessioni create allora hanno contribuito a garantire
oggi, negli Atenei italiani, la presenza di docenti di Letteratura per l'infanzia che non si sentono figli di un dio
minore ma integrano con passione e competenza i vari settori della nostra
disciplina. Insomma credo che ormai, almeno a livello accademico e di docenza,
i due grandi pregiudizi siano stati sconfitti.
Hai trovato alleati in questa impresa? Quali?
È difficile guardare indietro senza ricordare
che all'inizio il mio passaggio accademico da Letteratura italiana contemporanea a Letteratura per l'infanzia fu guardato con un certo stupore e
francamente a livello universitario mi sono mosso abbastanza da solo; quindi
pochi alleati ma neppure ostilità.
Più che riscoprire ritengo importante il
mantenimento di uno standard qualitativo da parte della nostra editoria: meno
serialità, meno romanzi costruiti a tavolino e maggiore valorizzazione dello
stile dei singoli autori; è quello che gli editori di albi per i più piccoli (e
non solo) fanno ormai da anni.
Le scuole sono preparate a questo compito?
Ritengo che la generazione degli insegnanti, quella uscita dai corsi di Laurea in Scienze della Formazione primaria, possa avere una buona preparazione in materia, ma ovviamente fra la preparazione teorica e quella pratica esiste il gusto individuale per la lettura e la capacità di renderlo "attivo" con i propri alunni. Voglio dire che un insegnante "lettore debole" potrà fare ben poco per trasmettere emozioni e valorizzare lo spazio della lettura. Dopo gli attacchi al Cuore di De Amicis, sferrati senza esclusione di colpi a tal punto da farci vergognare per averlo amato, tu gli dedichi un libro…
Il "caso De Amicis" è davvero
straordinario: come ha scritto Alberto Asor Rosa Pinocchio (1881-1883) e Cuore
(1886) sono stati i due testi fondamentali dell'Italia bambina, hanno contribuito più di altri a formare
l'immaginario degli Italiani. Cuore ha
moltissimi dei difetti che gli sono stati addebitati, ma la sua importanza
storica va al di là delle stesse "cadute" moralistiche, inoltre tutta
la produzione per adulti di De Amicis, "soffocata" dal successo di Cuore, merita di essere considerata
perché è nata all'insegna di un impegno ad allargare il numero dei lettori
trattando temi quali l'esercito, i viaggi, la scuola, la vita quotidiana.
Sarà perché da ragazzo sono stato accanito
lettore salgariano ma considero Salgari il terzo "grande" della
letteratura per ragazzi (e non solo) dell'Italia postunitaria; ovviamente non
mi riferisco all'aspetto stilistico ma alla capacità di articolare uno spazio
dell'avventura in tutti gli angoli del mondo, di creare figure di grande
rilievo per l'immaginario, di costruire eroi capaci di stare dalla "parte
giusta" contro soprusi e prepotenze.
A questo lavoro, legato ad una dimensione più
divulgativa anche se rigorosa dal punto di vista della ricerca, unisco la terza
edizione aggiornata del mio Una storia,
tante storie. Guida all'opera di Gianni Rodari appena uscito da Einaudi
ragazzi; si tratta - credo - di una lettura complessiva e organica dell'opera
rodariana alla luce dell'idea che Rodari non fu solo uno scrittore per
l'infanzia ma un intellettuale del nostro Novecento capace di unire alla
produzione per bambini una capacità di analisi culturale che si esplicitò nella
sua attività di giornalista che
transitava dalla cronaca al commento politico, dalle osservazioni di costume
alla riflessione pedagogica.
Hai scritto più volte su di lui, lo presenti in varie scuole ,
incontri docenti di scuole di ogni ordine e grado. Trovi risonanza nei docenti
di oggi?
Più che risonanza trovo molta attenzione,
molta voglia di conoscere Rodari dai diversi punti di vista; è per questo che
la sua storia è molteplice e trova
ancora riscontro a diversi livelli. Credo, insomma, che si possa parlare di un
Rodari utilissimo alla scuola di oggi.
È sempre difficile dare consigli, ma quando
rivedo Rodari in alcune vecchie trasmissioni televisive o guardo le sue foto
circondato dai bambini mi rendo conto che la sua "formula" era quella
della semplicità d'approccio senza "bamboleggiamenti" o atteggiamenti
moralistici. Il bambino - diceva - vuole crescere ma noi non dobbiamo calargli
dall'alto i contenuti ma accompagnarlo in un percorso di scoperta per farlo
"alzare ogni giorno un pochino".
Scheda
Pino Boero nasce a Genova dove vive e insegna
all'Università di Genova Facoltà Scienze della Formazione "Letteratura per
l'infanzia." Fra i massimi
esperti della Storia dell'Educazione e della letteraura per l'età evolutiva, dal
2002 al 2008 è stato Preside della Facoltà
ed ha collaborato con le università di tutto il mondo, Francia,
Svizzera, Svezia Argentina, Corea Brasile. Dirige la collana Memorandum per
Einaudi ed ha curato l'Opera omnia dello scrittore Gianni Rodari. Collabora con
varie riviste e soprattutto con la rivista Andersen dedicata a tutte le
pubblicazioni per ragazzi, ed è membro della Giuria del Premio omonimo. Molti i
volumi pubblicati, tra i quali:
1992 - Una storia tante storie Guida all'Opera di
Gianni Rodari (Einaudi) con
l'intento di sottrarre la letteratura per l'infanzia al limbo di una produzione
minore e restituirla alla complessità della storia della letteratura e
pedagogia.
1995 - con C. De Luca La letterarura per l'infanzia (Laterza) per
contestualizzare le vicende dell'editoria rivolta ai ragazzi.
1997 - Alla frontiera (Einaudi) uno scandaglio sui mondi, generi e
temi della letteratura per ragazzi.
2009 - con Giovanni Genovesi, Cuore - De Amicis tra critica e utopia
(Franco Angeli), lucida analisi della produzione di un autore capace di
guardare il mondo della formazione senza ignorare la complessità della scuola.
2011 - con Walter Fochesato e Felice Pozzo Il corsaro Nero (Franco
Angeli), una approfondita escursione nel mondo letterario e fantastico di
Salgari.
2014 - Il cavallo a dondolo e l'infinito (Interlinea), una cavalcata ideale su un ideale cavallo la
dondolo, metafora della progettualità fantistica nell'infinita rappresentazione di temi e
autori per l'infanzia.
2019 con Walter Fochersato L'alfabeto di Gianni (Coccolebooks) per
raccontare in 21 storie la vita del nostro più importante autore di letteratura
per ragazzi
2020 - Una storia tante storie Guida all'Opera di Gianni Rodari
(Einaudi) Terza Edizione aggiornata.
A cura di Pasquale Lubrano Lavadera
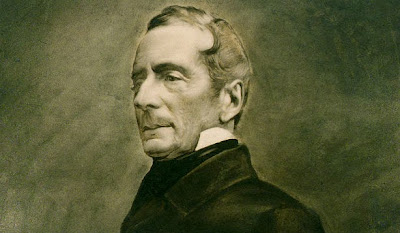


Commenti
Posta un commento