Procida Capitale Italiana della Cultura: Due Figure di rilievo Giuseppe Imbò e Antonio Parascandola
 |
| Antonio Parascandola |
I
libri più importanti sulla storia di Procida sono stati scritti alla fine
dell'ottocento poi per mezzo secolo il grande silenzio e la grande oscurità. In
tale buio due luci due grandi nomi Giuseppe Imbò e Antonio Parascandola docenti
universitari e ricercatori scientifici che
con i loro studi e le loro ricerche hanno tenuto alto il nome di Procida
a livello culturale. Due figure che andrebbero rivisitate e fatte conoscere ai
cittadini italiani.
Se
oggi Procida ha meritato il titolo di Capitale della Cultura lo si deve anche a loro, al loro impegno
strenuo di formazione degli studenti
universitari e ai risultati scientifici raggiunti grazie alla loro forte
passione per la ricerca.
Giuseppe
Imbò (1899-1980) geofisico,
sismologo, fu prima assistente di Alessandro Malladra all’Osservatorio
Vesuviano, poi, dal 1929, direttore dell’Osservatorio di Catania. Presidente
dell'Associazione geofisica italiana, venne nominato direttore dell’OV nel
1935. L’anno successivo ottenne inoltre la cattedra di Fisica Terrestre
dell’Università di Napoli. Imbò diede inizio a un vasto programma di lavori di
riammodernamento della struttura dell’OV, che prevedeva la sostituzione di
alcune strumentazioni soprattutto sismiche con altre più idonee. Tale programma
tardò a realizzarsi a causa dell’avvento della seconda guerra mondiale; non
vennero tuttavia mai sospese le osservazioni meteorologiche, vulcanologiche e
sismiche, anche quando l’Osservatorio vesuviano fu requisito dalle truppe
alleate. In queste circostanze avvenne l’eruzione del 1944, che Imbò studiò
approfonditamente, nonostante i pochi mezzi a sua disposizione.
Il programma di riammodernamento fu ripreso al
termine della guerra, e con Imbò iniziò una stretta collaborazione dell’OV con
l’Istituto Nazionale di Geofisica, e con ricercatori giapponesi. Gli studi di
Imbò riguardarono soprattutto la vulcanologia fisica e la sorveglianza
geofisica dei vulcani.
Tra i suoi scritti ricordiamo: Appunti delle
lezioni di vulcanologia ORUN, Fenomeno bradisismo flegreo e sue
conseguenze, Indagine sulla radioattività naturale, Lave
vesuviane, Il Vesuvio e la sua storia Edizioni scientifiche
Italiane.
Antonio Parascandola, nel 1928 si laureò in Chimica e nel 1929 conseguì una
laurea in Farmacia, entrambe presso l'Università di Napoli. L'anno successivo si abilitò alla professione di farmacista. Tuttavia non
seguì le orme paterne, preferendo seguire la passione per la mineralogia e la vulcanologia che lo portò a pubblicare diversi articoli scientifici, i quali gli
valsero, già nel 1931, la nomina di assistente incaricato presso l'Istituto di
Geologia e Mineralogia Agraria del Real Istituto Superiore Agrario di Portici. In seguito alla sua produzione scientifica, nel 1936 conseguì la libera
docenza in vulcanologia e nel 1937 in geologia fisica.
Professore incaricato di Mineralogia e Geologia nel corso di laurea in
Ingegneria si interessò alle eruzioni del Vesuvio e in particolare raccontò da testimone diretto l'ultima eruzione del Vesuvio del 1944, approfondendo scientificamente i processi di segregazione della tenorite e della cotunnite. Negli anni successivi si dedicò alle ricerche
di mineralogia e petrografia nelle aree vesuviana e flegrea con riferimento all'attività
della solfatara e del bradisismo, che fu oggetto della sua ultima pubblicazione nel 1972.
Collaborò all'aggiornamento della carta geologica d'Italia e alla redazione
della voce "Terra" per l'Enciclopedia
Treccani, lasciando infine una produzione scientifica
rappresentata da circa 60 lavori pubblicati, riguardanti in massima parte
il Vesuvio e i Campi Flegrei.
Nel 1990 fu costituito presso il Dipartimento di Agraria dell'Università Federico II il Museo di Mineralogia a lui intestato. In suo onore è stata
denominata la parascandolaite,
minerale scoperto nel 2013 tra i
materiali prodotti dall'eruzione del Vesuvio del 1944.
Tra le sue pubblicazioni Il Vesuvio e le sue eruzioni L'eruzione
vesuviana del marzo 1944, Napoli, Genovese, 1945, Il Monte Nuovo e
il lago Lucrino, Napoli, Genovese, 1946, I fenomeni bradisismici del
Serapeo di Pozzuoli, Napoli, Stab. tip. G. Genovese, 1947.


.jpg)
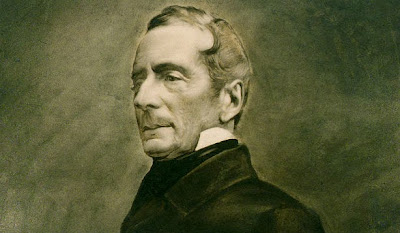


Commenti
Posta un commento